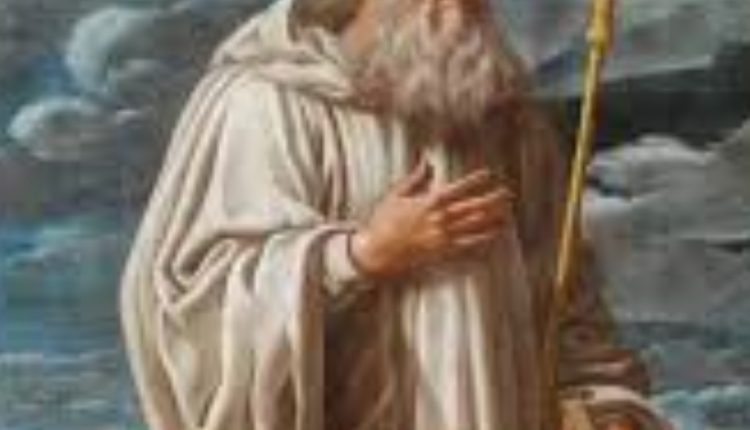Per il numero consueto della rubrica “Spiccioli di spiritualità” diretta dal prof. P. Vitale, il prof. Michele Pugliese ci parla di San Benedetto da Norcia.
C’era un tempo in cui le maestre, per indicare l’arrivo della primavera, dicevano ai loro alunni: “san Benedetto, la rondine sotto il tetto”, indicando con ciò il fatto che l’arrivo della bella stagione induceva le rondini a fare il nido proprio intorno al 21 marzo che, come ben si sa, è il momento ufficiale dell’ingresso della primavera. A parte il cambiamento climatico, per cui dubito che le rondini facciano il nido proprio il 21 marzo, il fatto è che anche la festività di San Benedetto è traslocata dal 21 marzo all’11 luglio.
Come mai? Forse non tutti sanno che molti santi nel corso degli ultimi anni hanno trovato una collocazione diversa da quella tradizionale, per cui ci sono oggi alcune persone che giustamente festeggiano (ma ci sono ancora persone che festeggiano il loro onomastico in una società secolarizzata e comunque con nomi dati ai nascituri di cui traccia di santità pregressa stenta a ritrovarsi?) nella vecchia data, mentre il Vaticano per decreto ha rimescolato un poco le carte. Precisamente fu Paolo VI nel 1969, in attuazione della Costituzione liturgica ‘Sacrosanctum Concilium’ del Concilio Vaticano II a eliminare i santi di cui non c’erano tracce storiche certe e, in base a precisi criteri storiografici, a determinare le nuove date di ricorrenza, considerando l’antico uso cristiano di commemorare ogni anno i martiri nel giorno della loro morte, detto ‘Dies Natalis’, perché era quello della “nascita al cielo”.
Dunque anche San Benedetto da Norcia ha subito questo spostamento, ma non per commemorare il giorno del suo ‘transito in cielo’, che effettivamente è avvenuto il 21 marzo, ma quello dell’11 luglio, perché quella data è stata scelta per commemorare il suo patrocinio, ovvero il giorno in cui è stato proclamato patrono d’Europa da Papa Paolo VI nel 1964.
Dal libro dei ‘Dialoghi’ di papa Gregorio Magno, scritti intorno al alla fine del VI secolo con lo scopo di far conoscere la santità dei Padri d’Italia, veniamo a conoscenza che Benedetto nacque a Norcia, nella Sabina (oggi in provincia di Perugia), da una famiglia piuttosto agiata, che gli poté fornire in casa una prima istruzione scolastica. Poi fu mandato a Roma a proseguire gli studi, ma provò disgusto per la vita di quella città, specialmente a causa dei costumi licenziosi dei giovani suoi coetanei. Abbandonò dunque la città senza finire gli studi e si recò ad Affile, verso Tivoli, a circa 60 chilometri da Roma, per intraprendere una vita ascetica corrispondente ai suoi desideri. Dopo qualche anno si ritirò presso Subiaco, in un completo isolamento dal mondo. Qui trovò un monaco, di nome Romano, il quale lo rivestì con l’abito monastico e gli assicurò il minimo necessario al suo mantenimento. In tal modo Benedetto poté realizzare l’esperienza di vita eremitica che tanto successo aveva avuto nel vicino Oriente, senza disdegnare di insegnare le principali verità di fede ad alcuni pastori del luogo che erano a digiuno di dottrina cristiana. Dopo questo periodo, in cui subì varie tentazioni che riuscì a superare con l’aiuto della grazia, divenne monaco maturo per insegnare anche agli altri la pratica della vita monastica e fece ritorno a Subiaco dove intanto accorrevano sempre più fedeli attratti dalla sua fama di santità. Per essi provvide in breve tempo a creare dodici piccoli monasteri, assegnando a ognuno dodici monaci e un abate. La sua fama si estese anche fuori, tanto che venivano da Roma giovani di famiglie patrizie attratti dal nuovo genere di vita.
Il successo del santo suscitò l’invidia di un prete della zona, un certo Fiorenzo, che tentò di avvelenarlo e, non riuscendovi, mandando un gruppo di ragazze ad insidiare la virtù sua e dei suoi discepoli. Inutile dire che il tentativo fu vano e Benedetto, disgustato da tanta malvagità, lasciò Subiaco per portarsi altrove con un piccolo gruppo di monaci. Si diresse verso la città laziale di Cassino sulla cui vetta del monte adiacente fondò il famoso monastero che segnò una svolta nella sua vita e in quella del monachesimo occidentale. Infatti, pur mantenendosi distaccato dal mondo, a Montecassino i monaci passarono dall’isolamento più assoluto, al contatto con i piccoli insediamenti di quella regione con un’opera evangelizzatrice verso la popolazione rurale che ancora in massima parte aderiva al paganesimo.
L’eredità di san Benedetto è enorme, ai suoi monaci e a tutto il monachesimo d’Occidente lasciò in eredità una Regola che riesce a contemplare un forte spiritualità insieme al lavoro manuale (descritto nella famosa regola ‘ora et labora’) contribuendo a rilanciare l’economia del tempo che atrofizzava dopo la caduta delle strutture dell’impero romano. Dopo la sua morte, avvenuta nel 547, la sua regola fu adattata alle varie situazioni e nel corso dei secoli divenne la base per l’unificazione cristiana dell’Europa, realizzata poi politicamente da Carlo Magno nell’800, per cui si può dire che fu alla base di una società cristiana ed europea ben prima che nascessero le grandi nazioni e ben prima che nascesse quella Comunità Europea che nel 2004 tentò di darsi una Costituzione che spudoratamente non menzionava le radici cristiane dell’Europa, il cui tentativo fallì miseramente (non solo per questo naturalmente).
Per conoscere pienamente l’afflato spirituale del santo citiamo un passo della sua famosa regola: “Come vi è uno zelo cattivo, lo zelo dell’amarezza, che separa da Dio, così vi è uno zelo buono, che allontana dal peccato e porta alla vita eterna. È questo lo zelo che i monaci devono avere e praticare con l’amore più ardente. Si prevengano nello stimarsi a vicenda, sopportino con grande pazienza le loro debolezze fisiche e morali, facciano a gara nell’obbedirsi a vicenda, non ricerchino ciò che ritengono utile per sé, ma quanto è di vantaggio per gli altri; pratichino con purezza di cuore la carità fraterna; temano Dio perché lo amano; nulla antepongano a Cristo, e che egli ci conduca tutti insieme alla vita eterna”.