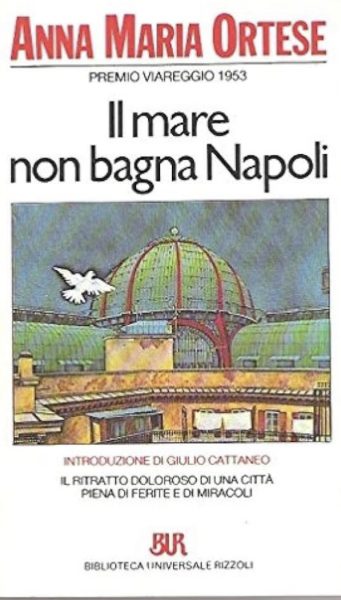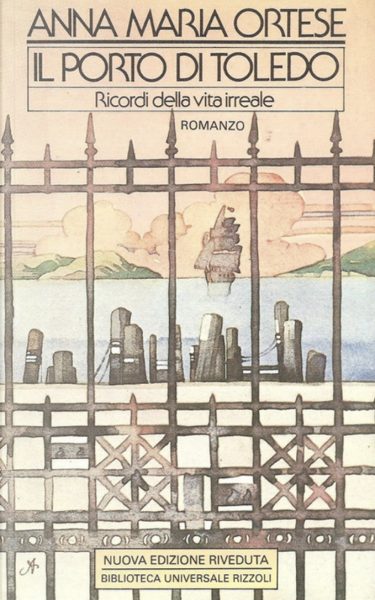Per il numero di marzo della rubrica “Il Novecento delle donne”, il prof. Pietro Salvatore Reina ci parla di A. M. Ortese.
A.M. Ortese è una delle più grandi voci letterarie del Novecento italiano, eppure, allo stesso tempo, non è molto conosciuta. Forse a causa della sua scrittura poco agile, o del complesso apparato simbolico e tematico dei suoi libri.
Nasce a Roma il 13 giugno da una famiglia numerosa e molto povera, che si trasferisce in diverse città prima di stabilirsi nel 1928 a Napoli. Quasi autodidatta – la formazione scolastica costituita solo dalle scuole elementari e da un anno di una scuola commerciale – Anna Maria si cimenta nel disegno e nello studio del pianoforte, ma infine si appassiona alla letteratura e scopre la propria vocazione di scrittrice. La mancata formazione scolastica fa risaltare ancor più la perfezione stilistica della sua opera, e lo stupore e la meraviglia che essa suscita nel lettore.
Nel 1933 il fratello marinaio Manuele muore al largo dell’isola di Martinica; l’eco della tragedia, velata di rimpianto e ricordo,ricorrerà in tutta l’opera della scrittrice. Il 1933 è anche l’anno del debutto con la pubblicazione di tre poesie su «La Fiera Letteraria», tra cui una intitolata Manuele:
«(…) Tutto che ci rimane ormai di te, Manuele, è un nome solo; e dentro al petto un male
che a questo nome si confonde» (da La Luna che trascorre, ed. Empiria).
Anche un altro fratello marinaio, Antonio, da lì a poco morirà al largo delle coste dell’Albania e dal 1952, a seguito della morte di entrambi i genitori, il nucleo familiare della scrittrice si ridurrà alla sorella Maria, con la quale Anna Maria vivrà tutta la vita.
Esordisce, nel 1937, col volume di racconti Angelici dolori, che parvero richiamarsi al realismo magico di Massimo Bontempelli (1878-1960), autore tra l’altro di Il figlio di due madri (1929), incentrato su un inquietante caso di reincarnazione.
Tra il 1945 e il 1950 comincia a collaborare con la rivista «Sud», il che non le impedirà di trasferirsi da una città all’altra inseguendo un lavoro che le permetta di sopravvivere, quasi sempre accompagnata dalla sorella. Il rapporto sororale, essenziale nella vita della Ortese, sarà per lei anche fonte di perenne rimorso per la vita sacrificata della sorella. Infatti, Maria non si sposerà per rimanerle accanto e il suo lavoro, e successivamente la pensione (da impiegata alle poste), saranno quasi le sole fonti di sostentamento per entrambe, essendo i ricavi delle pubblicazioni sempre molto modesti. La sorella Maria, così come gli altri componenti della famiglia, prenderà corpo trasfigurandosi in alcuni personaggi dolorosi, eterei e senza tempo, fondamentali nell’opera della scrittrice (uno su tutti, Juana de Il Porto di Toledo).
Tra una città e l’altra, Ortese comincia a pubblicare alcune opere che non avranno mai un vero successo di vendite
Nel 1950 è pubblicato L’infanta sepolta:
«Ho abitato a lungo in una città veramente eccezionale. Qui per non solo quale bizzarria della natura tutte le cose, il bene e il male, la salute e lo spasimo, la felicità più cantante e il dolore più lacerato, santità e dissolutezza, pietà e voluttuosa ferocia, troni e galere, mercati ed altari, patiboli e giostre, i canti di gioia degli eletti e il singhiozzo lamentevole del dannato. Tutte queste voci erano così saldamente strette, confuse, amalgamate tra loro che il forestiero che giungeva in questa città ne aveva a tutta prima un’impressione stranissima».
È la “stranezza” continua che suscita l’esperienza della vita stessa, che nella Ortese è sempre “cosmica”, una viva relazione fra tutte le creature viventi, da cui non è esclusa la pietra (e dunque la terra e i suoi abitanti come “corpo celeste”, mai separato dall’universo): la scrittura raccoglie e restituisce questa relazione assecondandone il movimento, operando nello stesso senso della vita e della natura, per somiglianze, per spostamenti, per metafore.
Con Il Mare non bagna Napoli, nel 1953, (Premio Viareggio, 1953) arriverà una labile notorietà, non scevra da forti polemiche per via delle critiche mosse nel libro al gruppo di intellettuali napoletani che si raccoglie intorno alla rivista «Sud»; la scrittrice mai rinuncerà a posizioni critiche nei confronti del mondo letterario dal quale si sente ingiustamente respinta e a cui sente di appartenere a tutti gli effetti. Dalle lettere agli amici, dalle rare interviste concesse, il desiderio di essere riconosciuta come “scrittrice”, come “narratrice”, sarà sempre un punto dolente nella vita di Ortese. Dagli intensi scambi epistolari fra la scrittrice e amici, quali Pietro Citati e Dario Bellezza, si possono cogliere momenti intimi e aneddoti, di alcuni dei quali è possibile trovare un’eco nell’opera della Ortese. Sarà Dario Bellezza nel 1986 a promuovere la raccolta di firme fra amici e intellettuali affinché le venga assegnata la pensione prevista dalla legge Bacchelli. La scrittrice confessò, in una lettera al poeta-amico, di essere stata sfrattata dalla casa di Rapallo, città scelta come ultimo porto. Il poeta Bellezza rese pubblico quanto successo e avviò la petizione.
Nel 1967 con Poveri e semplici vince il Premio Strega. La Ortese era stata imposta agli ‘amici della domenica’ con una campagna martellante da Maria Bellonci e da Alfonso Gatto, suoi facinorosi protettori; mentre l’avevano presentata Alberto Moravia e Giovanni Macchia. Queste illustri credenziali, purtroppo, non bastarono.
Nel 1975 viene pubblicato Il porto di Toledo, uno dei romanzi più estremi della scrittrice, resoconto visionario di un mondo dove “tutto ciò che si vede o accade è incantato o spaventoso”.
Nel 1986 L’Iguana. Un libro a più strati, una favola nera, una parabola a difesa degli ultimi, una denuncia dello sfruttamento della natura e degli animali, un racconto di viaggio e di avventura. Il libro, uscito la prima volta nel 1965, vendette 1990 copie nei primi cinque anni. Fu ripubblicato varie volte, fino a raggiungere il vasto pubblico con l’edizione Adelphi del 1986 caldeggiata da Pietro Citati. Una piccola curiosità: è con Bestie di Federigo Tozzi (Siena 1883 – Roma 1920), il più grande scrittore senese del Novecento, che nel Novecento gli animali ritornano nel bosco della letteratura.
Solo in tarda età, esattamente nel 1993 a 79 anni, la Ortese riuscirà ad avere un maggior successo di pubblico con Il Cardillo addolorato, edito da Adelphi, casa editrice che già dal 1986 cominciò a ristampare tutte le sue opere (in collaborazione con l’autrice stessa) in modo da formare un corpus rivisitato e organico.
Un romanzo «che tratta di Amori e Assassini» con la leggerezza dell’opera buffa. «In nessun altro libro, nemmeno nell’Iguana, che è il suo altro capolavoro, Anna Maria Ortese aveva mai posseduto questa forza:un’immaginazione così sovrana, una sapienza simbolica così ricca, un’arte così fresca e delicata» (Pietro Citati).
La Ortese muore il 9 marzo nel 1998, tre anni dopo la sorella Maria.
Infine, è la lettura del delizioso Pellegrinaggio alla tomba di Leopardi di Anna Maria Ortese suggerisce al regista Mario Martone il titolo del suo film
«In un paese di luce, dorme, da cento anni, il giovane favoloso[…]»
una definizione sorprendente, efficace, era quello che noi sentivamo in Leopardi: una dimensione visionaria e aperta, una capacità creativa straordinaria.