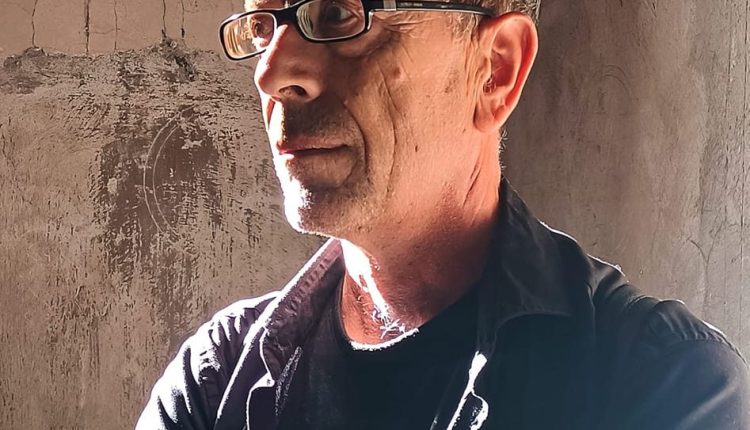È stato un dialogo serrato, stimolante, profondo e sicuramente gratificante quello che si è sviluppato nell’arco di un’ora durante la quale abbiamo discusso non solo del ruolo dell’IA (intelligenza artificiale nell’arte) ma anche delle implicazioni culturali e filosofiche della tecnologia, del manierismo nell’arte contemporanea e del significato della creatività nell’epoca digitale.
Intelligenza artificiale: strumento o creatore?
D: L’IA può essere considerata uno strumento al pari di un pennello nelle mani di un artista o rischia di sostituire l’artista stesso?
M.S.: La tecnologia ha sempre spinto l’arte avanti. Leonardo da Vinci ha rivoluzionato la pittura grazie all’uso dell’olio che ha permesso la sfumatura dei contorni e la creazione di un realismo mai visto prima. Oggi l’intelligenza artificiale rappresenta un nuovo strumento, ma il punto è capire se possa fare il salto da strumento a creatore. Al momento, l’IA è ancora un’arte di maniera. Analizza milioni di immagini e riproduce stili esistenti, ma non ha ancora creato qualcosa di autenticamente originale. Finché non sarà in grado di superare il manierismo e generare un’opera logica, che non si limiti a rielaborare schemi preesistenti, non potremo parlare di una vera rivoluzione artistica.
D: Ma allora, cosa accadrebbe se chiedessimo all’IA di creare un’opera che non imiti alcuna corrente o artista in particolare?
M.S.: Proverà comunque a rifarsi ai grandi artisti della storia, perché la sua capacità di creazione deriva dall’elaborazione di dati pregressi. Anche noi, in fondo, facciamo lo stesso: nessuno crea dal nulla. Ma la differenza è che l’artista umano è capace di andare oltre, di trasgredire e di rompere le regole per crearne di nuove.
L’intelligenza artificiale e i limiti etici
D: L’IA non è solo un fenomeno artistico, ma anche uno strumento che può avere conseguenze pericolose. Cosa ne pensa del suo utilizzo nei contesti bellici?
M.S.: Questo è il vero problema. L’intelligenza artificiale è stata utilizzata da taluni eserciti per identificare e colpire obiettivi umani. Questo porta a una riflessione più ampia che da un lato porta a concludere che la tecnologia sia sempre neutrale, e che il vero problema sia l’uso che ne fa l’essere umano. Del resto Isaac Asimov aveva già previsto tutto questo con le “tre leggi della robotica” che stabiliscono che nessun robot può fare del male a un essere umano. Ma nel momento in cui l’IA viene addestrata per uccidere, si rompe un precedente etico gravissimo. L’arte, in questo senso, potrebbe essere uno spazio di riflessione per questi temi.
Il manierismo nell’arte contemporanea
D: Abbiamo parlato di IA e manierismo. Ma il manierismo non è forse un problema anche per gli artisti umani?
M.S.: Il manierismo è un male che affligge l’arte contemporanea. Troppo spesso vediamo artisti che si limitano a dipingere “alla maniera di” qualcuno. Ma l’arte non dovrebbe essere ripetizione, bensì ricerca. Ci sono due elementi che distinguono un vero artista: la tecnica, che può essere usata o persino non usata. Pensi a un chitarrista che suona due sole note, ma le mette nel posto giusto, nel momento giusto.
D: Professore, dunque, lei vorrebbe far passare il messaggio che l’opposto del manierismo sia la capacità di portare avanti il linguaggio dell’arte, di spostarlo un po’ più avanti rispetto a ciò che è stato fatto prima?
M.S.: Le faccio un esempio: se Caravaggio fosse stato solo un grande tecnico della pittura, non sarebbe stato Caravaggio. La sua rivoluzione non è stata la sua tecnica, ma la sua visione. Ha rappresentato il sacro come mai era stato fatto prima, dipingendo San Pietro con i piedi sporchi perché era un pescatore, un uomo vero. Quello fu un salto concettuale che va oltre la semplice tecnica.
D: Eppure il pubblico sembra apprezzare il manierismo. Perché?
M.S.: Perché anche gli esseri umani tendono a essere manieristi. Ci piace riconoscere le cose, trovare rassicurazione nella ripetizione. Ma il compito dell’arte è rompere questa abitudine, spostare il limite, non rimanere dentro schemi preconfezionati.
Cattelan e il circo dell’arte contemporanea
D: Se il sistema dell’arte è un circo, Maurizio Cattelan è il re dei clown?
M.S.: Cattelan è geniale perché mette in scena il sistema dell’arte per quello che è. La sua opera “Comedian” (la banana attaccata al muro con il nastro adesivo) è una performance più che una scultura. Lui non ha creato un oggetto, ha creato una storia, un fenomeno mediatico. L’opera in sé non conta, conta il fatto che sia stata venduta per milioni e che, ogni volta che “qualcuno la mangia”, si genera un nuovo ciclo della performance. Il sistema dell’arte è una macchina commerciale che si autoalimenta. Se sei dentro il sistema, puoi provare a sfruttarlo come fa Cattelan, ma alla fine ci sei dentro. Cambiare un sistema dall’interno è quasi impossibile.
Dio, la scienza e l’intelligenza collettiva
D: Abbiamo parlato di IA e di collettività. Ma se mettessimo insieme più intelligenze artificiali, creerebbero una sorta di mente alveare?
M.S.: Questa è una domanda fondamentale. Se metti cento intelligenze artificiali in rete, è molto probabile che inizino a interagire tra loro come un’unica entità, proprio come avviene negli sciami di api. E con i computer quantistici, questo scenario potrebbe diventare ancora più probabile.
Professore, la ringrazio per questo suo contributo in tema di I.A. e Arte che ha aperto scenari straordinari, ma anche interrogativi complessi. È uno strumento o un creatore? Resterà manierista o diventerà autenticamente creativa? E se arrivasse a generare una coscienza collettiva, cosa significherebbe per noi? L’arte è sempre stata una chiave per comprendere il mondo, e anche oggi, nell’era digitale, resta un campo di battaglia per le idee. La sfida, ora, è capire se il futuro dell’arte sarà fatto dall’uomo, dalle macchine o da entrambi.